Il cuore del Borgo
In altri tempi il Borgo portava “la Titina” per le strade del paese. Era, questa, la rappresentazione di una vecchia popolana ottenuta riempiendo di paglia vecchi abiti in disuso che erano sostenuti da una precaria struttura di legno. Correvano i primi anni ’60 del secolo scorso. La vecchia era caricata sul cassone di uno sfiatato furgone, momentaneamente sottratto a più gravose incombenze, e portata per le vie del paese da una comitiva di “borgaioli” che cantavano vecchi stornelli o motivetti di estemporanea creazione, ballavano con la vecchia, indirizzavano lazzi e derisioni verso i rioni rivali e i loro sostenitori.
A quei tempi la festa del falò si limitava alla preparazione e all’accensione dei pagliai, allo scoppio dei mortaretti di artigiana fabbricazione e a poche iniziative di contorno, fra cui, appunto, la ronda della “Titina”. Chi scrive e ricorda, é salito sul cassone di quel furgone con la Titina il giorno di S. Giuseppe del ’65. Accompagnare la Titina nella ronda per le strade del paese era privilegio riservato a pochi e certamente sufficiente a riempire d’orgoglio il cuoricino di un bambino per il semplice fatto di essere lì, sul carro del Borgo insieme alla Titina e ai “duri” del rione. Alla vecchia ahimè, a quel punto restavano pochi minuti di esistenza, essendo destinata a finire sulla punta dello zerbale e bruciare fra le fiamme del falò. Con la vecchia sarebbero bruciati i cattivi presagi e le antiche preoccupazioni. Le fiamme, quando si levavano immense, avvolgevano insieme ai vecchi e logori abiti, quanto di brutto il passato si trascinava dietro e illuminavano la speranza in un futuro senz’altro migliore.
Tutte le componenti dei botti, che da sempre accompagnano l’accensione dei pagliai, in quegli stessi anni, venivano fabbricati artigianalmente e in larga autonomia. Insomma tutto era preparato”in casa” dagli esperti artificieri del rione. Si cominciava con l’acquisto e lo stoccaggio degli ingredienti della polvere esplosiva (clorato di potassio e zolfo). Questi erano poi miscelati secondo dosi e conoscenze che si tramandavano di generazione in generazione, continuamente modificati in conformità con l’esperienza acquisita e con l’avanzare della tecnologia di costruzione dei mortai d’esplosione. Il risultato era una miscela altamente esplosiva per semplice compressione, ma poco infiammabile. Se ne preparavano quantitativi industriali che erano stoccati in bidoni di latta che potevano contenerne fino a un chilogrammo ciascuno. In quegli anni, nella cantina di Gigetto, all’erta del Borgo, si accatastavano pile di bidoni che coprivano un’intera parete fino al soffitto.
I mortai d’esplosione, ovvero i “mortaretti” veri e propri, che fossero singoli o a batteria, uscivano per lo più dalle cavernose e generose fucine de’ “Biozz”. Mentre i mortaretti singoli erano destinati a un uso individuale ed estemporaneo, quelli che contavano per il rione erano le batterie: da sei, da dieci, da dodici camere d’esplosione. I mortaretti erano blocchi d’acciaio pieno a sezione quadra di varia lunghezza, in cui venivano ricavati fori del diametro di circa un pollice, profondi 4/5 centimetri (le camere di scoppio). In corrispondenza di ogni foro veniva saldato uno spezzone di catena che terminava con un cilindretto in acciaio di dimensioni sufficienti per entrare di misura nella camera di scoppio. Per caricare i mortaretti s’inseriva, con un cucchiaio, una certa quantità di miscela esplosiva all’interno della camera di scoppio e poi si chiudeva il foro con il cilindretto (a mo’ di tappo). Quando l’operazione era stata portata a termine per tutti i fori di cui era composta la batteria era sufficiente colpire con una mazzetta da muratore la testa del cilindretto che fuoriusciva dal foro per ottenere l’esplosione. Un certo numero di mortaretti, ognuno di questi con più fori (appunto sei, dieci, fino a dodici), che esplodevano la loro potenza di fuoco in maniera organizzata, coordinata, cadenzata, dava origine a sinfonie infernali, capaci di far tremare i vecchi muri delle case del Borgo.
In quegli anni, era consuetudine sparare le micidiali raffiche di botti nell’angusto spazio fra le alte case ai piedi dell’erta del Borgo che si affaccia sul fiume Montone, all’inizio del loggiato che porta alla Piazza, dove oggi si trova il negozio del fornaio. Si voleva così sfruttare l’effetto acustico che si generava avendo le alte case alle spalle, le quali amplificavano i botti e allo stesso tempo li indirizzavano, attraverso l’apertura a picco sul fiume, direttamente verso il ponte di V. Guerrazzi, dove si trovava molta della gente che partecipava alla festa del paese, e a contrastare le batterie di mortaretti del rione Mercato, piazzate sotto lo stesso ponte. Quando partivano le raffiche, che poi si ripetevano in rapida e cadenzata successione per alcuni interminabili minuti, il fumo dei botti e l’acre odore dell’esplosivo rendevano l’aria irrespirabile. Gli artificieri, selezionati e impavidi giovani del rione, dal braccio robusto e dal polso fermo, vestiti nelle più strambe combinazioni guerriere, naso e bocca coperti dai fazzoletti, il capo protetto da caschi da motociclista o da elmetti residuati bellici, uscivano sempre dal campo di fuoco con un principio d’intossicazione ma sicuri di un’altra vittoria per l’intensità dei botti, la musicale cadenza delle raffiche, la perizia e la prontezza nella ripetizione delle sequenze.
Successivamente le batterie del Borgo vennero spostate sul greto del fiume, qualche decina di metri a monte del falò che bruciava e forniva la luce indispensabile alle operazioni. Il muraccio di cemento, che ora separa le case del Borgo dal fiume, ancora non era stato costruito e non c’era nessuna soluzione di continuità fra rione e fiume. Lo spazio fra case e alveo era occupato dagli orti e, a quei tempi, anche il fiume era diverso. Le sponde erano basse e l’alveo sassoso degradava dolcemente dagli orti fino all’acqua. Questa morfologia e l’assenza di barriere artificiali permettevano una naturale e quotidiana frequentazione dell’alveo del fiume: le lavandaie che lavavano i panni, i pescatori con le canne, i bambini che giocavano, tutti che, tempo permettendo, facevano il bagno.
All’area del falò del Borgo si accedeva attraverso la scalinata del voltone di “Sotacà”. Discesa la ripida gradinata si girava attorno alla “Ca’ de’ Brusè”, una casina abbandonata che ora non c’è più, poi la stradina continuava a scendere costeggiando il muro di cinta di un orto privato, passava lungo l’antico canale del mulino e infine scendeva al greto sassoso. Nel pomeriggio del 19 marzo, S Giuseppe e festività nazionale poi soppressa, mentre gli adulti rifinivano il pagliaio e preparavano le torcie per l’accensione, gli artificieri e gli aiutanti addetti al caricamento controllavano i mortai e i contenitori dell’esplosivo, le donne agghindavano “la Titina”, i bambini, si divertivano a far scoppiare “le mine” in giro per il paese e sull’alveo del fiume. “Le mine” erano botti ottenuti in maniera del tutto rudimentale che sfruttavano la facilità esplosiva della miscela di clorato di potassio. Era sufficiente depositare al suolo, su una superficie dura e liscia, una o più cucchiaiate di polvere e poi scagliarvi sopra un ciottolo di buon peso per ottenere una potente esplosione. Luogo preferito per le “mine” erano i gradini di accesso alla “Ca’ de’ Brusè”, vuoi per il luogo appartato, vuoi per il dislivello offerto dai gradini stessi, che facilitavano il lancio del ciottolo sulla polvere esplosiva. Anche i bambini avevano a disposizione, in quei giorni, discrete quantità di polvere esplodente perché tutto sommato era agevole sottrarla furtivamente dai depositi del Rione o perché, loro stessi sommariamente esperti nel reperimento degli ingredienti e nella fabbricazione della miscela, riuscivano in qualche modo a ottenere i quantitativi di polvere che servivano loro senza dipendere dagli adulti. I giovani “artiglieri” addetti alle batterie dei mortaretti del Borgo e incaricati di battersi allo stremo contro quelle dei rioni rivali erano guardati dai bambini con occhi pieni di rispetto e d’ammirazione: sognavano, per il futuro, di riuscire a far parte di quei pochi selezionati arditi. Nel frattempo, in aperta violazione delle raccomandazioni dei genitori, cercavano di imitarli come potevano.
Più tardi il muraccio di cemento venne elevato e la morfologia di luoghi tanto famigliari venne modificata. Cambiò anche la festa, ai falò e ai botti si aggiunsero carri sempre più grandi, belli e onerosi. I botti artigianali e i mortaretti vennero vietati e surrogati con fuochi artificiali meravigliosi, costosissimi e scarsi d’anima. Le mamme, i bambini e i giovani liberano la creatività e si dedicano alla confezione dei vestiti con cui abbigliarsi per seguire i carri nel tema che cambia di anno in anno.
Per qualche tempo, a fine anni ’70, il muraccio ospitò frotte di giovani trasgressivi che volevano partecipare appieno dell’atmosfera di festa e godimento che accompagna il lato del Borgo della festa dei falò. Poi anche quest’area del fiume fu vietata e, ancora oggi, ogni anno dobbiamo combattere ardue battaglie contro il resto del mondo per permettere, a chi lo desidera, di vivere la festa sulla riva del fiume.
Perchè quello che maggiormente c’interessa é dare continuità a una festa millenaria, fatta di gioia, creatività, lavoro comunitario, trasgressione e divertimento.
Nel lungo gioco di quel giorno, liberando fantasia e incoscienza, ritrovando l’innocenza, tutti ridiventano bambini. E questo è, in fondo, il cuore del Borgo.
















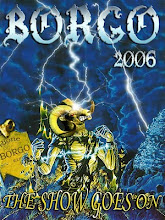

4 commenti:
è un cuore grande....rosso e blu!!!!
FOOOORZAAAAAAAAAAAAAAAAA BORGO!!!!!!
Interesting to know.
leggere l'intero blog, pretty good
Posta un commento